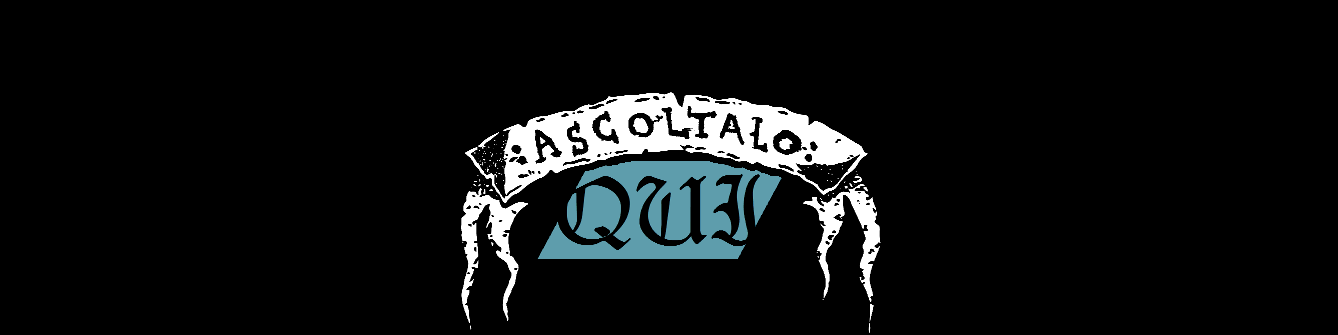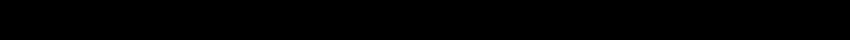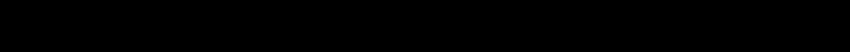Tra tutti i grandissimi mesi che ci si sarebbe mai potuti aspettare, il da un paio di settimane conclusosi settembre è stato senza dubbio il più grande – e di stacco per davvero. Così tanto di stacco differente e lontano da qualunque altra già pienotta mensilità goduta negli ultimi sei anni di attività e redazione della presente rubrica mensile, che l’articolo riepilogativo di oggi si presenta pertanto inedito in forma e speciale non solamente per la qualità complessiva esagerata dei dischi selezionati come crème dell’ultimo mese -una cosa invero e fortunatamente non così d’eccezione, considerata la squisita fattura di ciò che riteniamo esser degno di trattazione qui sopra- ma innanzitutto per un format a cinque (!) imperdibili album plurinominati (invece dei soliti quattro) con tanto di una doverosa aggiunta di coda finale fatta di un paio di ulteriori menzioni così onorevoli e apprezzate da meritarsi necessariamente una cospiqua descrizione di elogio a loro volta.
Ci sarà infine spazio anche per quache cosiddetta uscita minore, con i migliori EP ascoltati lungo il nono mese del 2023 menzionati e vivamente consigliati, ma le sorprese iniziano per assurdo da una assoluta garanzia: i Marduk del superlativo “Memento Mori” che, portandosi a casa una ovazione totale dallo staff, aprono le danze proverbialmente macabre regalando una lezione in corsi e ricorsi; in trasformazione e trasmutazione; in trasfigurazione di morte, vita e tutto ciò che vi sta in mezzo. Un’alchimia vera e propria che è impensabile trovare nei solchi incisi da band nel fiore della maturazione e all’apice della loro creatività – figurarsi in quelli nondimeno zenitali d’una celebrante oggi i cabalistici 33 anni dalla prima formazione.

![]() “È a buonissima ragione che “Memento Mori” può essere ritenuto uno dei capitoli più immancabili, riusciti, definitivi e pertanto rappresentativi dell’intera, titanica discografia attuale dei Marduk: con ogni probabilità il più coeso, coerente, puramente back-to-front, splendidamente continuo e ricco. Stilisticamente un mix del meglio di “Rom 5:12”, “Plague Angel” e “Frontschwein”, per dirne solo tre ma condendoli di una tutta nuova personalità, il full-length numero quindici della creatura attualmente rappresentata da Daniel Rostén, Morgan Håkansson e Simon Schilling scorre come una scrosciata di maledizioni ataviche e mefitica distruzione rimanendo sempre profondamente riflessivo nell’eccezionale e cadaverico gusto poetico, metrico e lirico sviluppato da Mortuus su canzoni che possono per la prima volta essere definite completamente quanto ineditamente sue. A dispetto di ciò, non avviene nessuna rivoluzione copernicana – tutto resta sigillato nel tempo così com’è, come dev’essere e come stregato sembra dalla più inspiegabile, mostruosa e prosaica delle magie che è destinata per diritto di nascita ad ognuno di noi: la morte.”
“È a buonissima ragione che “Memento Mori” può essere ritenuto uno dei capitoli più immancabili, riusciti, definitivi e pertanto rappresentativi dell’intera, titanica discografia attuale dei Marduk: con ogni probabilità il più coeso, coerente, puramente back-to-front, splendidamente continuo e ricco. Stilisticamente un mix del meglio di “Rom 5:12”, “Plague Angel” e “Frontschwein”, per dirne solo tre ma condendoli di una tutta nuova personalità, il full-length numero quindici della creatura attualmente rappresentata da Daniel Rostén, Morgan Håkansson e Simon Schilling scorre come una scrosciata di maledizioni ataviche e mefitica distruzione rimanendo sempre profondamente riflessivo nell’eccezionale e cadaverico gusto poetico, metrico e lirico sviluppato da Mortuus su canzoni che possono per la prima volta essere definite completamente quanto ineditamente sue. A dispetto di ciò, non avviene nessuna rivoluzione copernicana – tutto resta sigillato nel tempo così com’è, come dev’essere e come stregato sembra dalla più inspiegabile, mostruosa e prosaica delle magie che è destinata per diritto di nascita ad ognuno di noi: la morte.”
![]() “L’uomo, ancora vivo, imputridisce nella tomba invisibile del tempo – e tanto ne diventa consapevole, quanto più germoglia in lui il seme della follia: l’ammonimento dei Marduk non è certo materia inesplorata per una band che ormai da più di trent’anni adora la morte e ne porta fieramente i vessilli, ma la lucidità e la perizia con cui “Memento Mori” affonda i suoi colpi è semplicemente mozzafiato. Lasciata la trincea in favore di quel compendio occulto di oscurità medievale, antinomie religiose e fascino del grottesco mutuato dall’ovvia vicinanza con i Funeral Mist di un Mortuus in stato di grazia, i Marduk compongono uno dei dischi più riusciti della loro intera carriera; se la tombale “Shovel Beats Sceptres” rappresenta infatti la svuotante realizzazione della fine, la violenza del resto della tracklist non sovrasta né appiattisce in alcun modo l’eccezionale songwriting degli svedesi, tra brani che si incastrano l’uno nell’altro con grande ingegno e un’alchimia fra vocals e corde che porta inevitabilmente a spingere il tasto play una quantità di volte seriamente indefinibile.”
“L’uomo, ancora vivo, imputridisce nella tomba invisibile del tempo – e tanto ne diventa consapevole, quanto più germoglia in lui il seme della follia: l’ammonimento dei Marduk non è certo materia inesplorata per una band che ormai da più di trent’anni adora la morte e ne porta fieramente i vessilli, ma la lucidità e la perizia con cui “Memento Mori” affonda i suoi colpi è semplicemente mozzafiato. Lasciata la trincea in favore di quel compendio occulto di oscurità medievale, antinomie religiose e fascino del grottesco mutuato dall’ovvia vicinanza con i Funeral Mist di un Mortuus in stato di grazia, i Marduk compongono uno dei dischi più riusciti della loro intera carriera; se la tombale “Shovel Beats Sceptres” rappresenta infatti la svuotante realizzazione della fine, la violenza del resto della tracklist non sovrasta né appiattisce in alcun modo l’eccezionale songwriting degli svedesi, tra brani che si incastrano l’uno nell’altro con grande ingegno e un’alchimia fra vocals e corde che porta inevitabilmente a spingere il tasto play una quantità di volte seriamente indefinibile.”
![]() “Risulta quasi incredibile come dopo oltre tre decadi di carriera i Marduk continuino ad affinare una formula ormai infallibile e sempre più vicina alla perfezione. Il fatto che “Memento Mori” abbia richiesto qualche anno in più per essere disponibile al pubblico è giustificato dal fatto che il nuovo disco della band svedese è probabilmente il migliore dai tempi di “Serpent Sermon”: la tracklist scorre con una naturalezza semplicemente disarmante e la giusta dose di influenze stilistiche targate Funeral Mist vanno ad esaltare una macchina da guerra di per sè già perfettamente rodata. L’aggiunta di tantissimi piccoli dettagli e accortezze alle composizioni permettono alle tracce di susseguirsi una dietro l’altra senza avere mai la sensazione di essere sbattutti ogni volta di fronte allo stesso muro sonoro; infatti, nonostante la annichilente coesione, la facilità di riascolto di “Memento Mori” è persino superiore rispetto ai due comunque riuscitissimi capitoli precedenti. In definitiva i Marduk sembrano non avere intenzione di fermarsi nel loro perpetuo miglioramento – e noi non possiamo fare altro che goderne.”
“Risulta quasi incredibile come dopo oltre tre decadi di carriera i Marduk continuino ad affinare una formula ormai infallibile e sempre più vicina alla perfezione. Il fatto che “Memento Mori” abbia richiesto qualche anno in più per essere disponibile al pubblico è giustificato dal fatto che il nuovo disco della band svedese è probabilmente il migliore dai tempi di “Serpent Sermon”: la tracklist scorre con una naturalezza semplicemente disarmante e la giusta dose di influenze stilistiche targate Funeral Mist vanno ad esaltare una macchina da guerra di per sè già perfettamente rodata. L’aggiunta di tantissimi piccoli dettagli e accortezze alle composizioni permettono alle tracce di susseguirsi una dietro l’altra senza avere mai la sensazione di essere sbattutti ogni volta di fronte allo stesso muro sonoro; infatti, nonostante la annichilente coesione, la facilità di riascolto di “Memento Mori” è persino superiore rispetto ai due comunque riuscitissimi capitoli precedenti. In definitiva i Marduk sembrano non avere intenzione di fermarsi nel loro perpetuo miglioramento – e noi non possiamo fare altro che goderne.”
![]() “In fondo lo sapevamo tutti che il nuovo Marduk avrebbe davvero fatto faville, con il culto della Nera Signora finalmente ripreso da dove lo si era lasciato nell’anno Satani 2012 in favore di una piccola scampagnata tra le mine anticarro; e ciononostante qualsiasi lieta previsione in merito a questo “Memento Mori” -che di scontato avrà forse il titolo e nient’altro- finisce con lo sgretolarsi sotto i colpi di strumentali dall’intransigenza pari se non superiore a quanto sentito nei due belligeranti full venuti prima di lui. Poco senso ha pertanto discutere di cose come “funeralmistizzazione” della creatura di capitan Morgan, a meno che per certuni la voce di Mortuus e quei maledetti ottoni non siano talmente impressionanti da prendersi con la forza tutta la scena: la puzza di dannazione (le parti di basso incise per forza di cose da sei mani diverse) quando non di pura, letterale morte (la comparsa sul finale di un L.G. Petrov riemerso dall’aldilà e pertanto irriconoscibile) è la stessa che esala da tre decadi a questa parte dai terreni pestati con passo inarrestabile dagli svedesi, sui quali lo stivale dei Marduk si conferma quello capace di regalare i calci in bocca più dolorosi di sempre.”
“In fondo lo sapevamo tutti che il nuovo Marduk avrebbe davvero fatto faville, con il culto della Nera Signora finalmente ripreso da dove lo si era lasciato nell’anno Satani 2012 in favore di una piccola scampagnata tra le mine anticarro; e ciononostante qualsiasi lieta previsione in merito a questo “Memento Mori” -che di scontato avrà forse il titolo e nient’altro- finisce con lo sgretolarsi sotto i colpi di strumentali dall’intransigenza pari se non superiore a quanto sentito nei due belligeranti full venuti prima di lui. Poco senso ha pertanto discutere di cose come “funeralmistizzazione” della creatura di capitan Morgan, a meno che per certuni la voce di Mortuus e quei maledetti ottoni non siano talmente impressionanti da prendersi con la forza tutta la scena: la puzza di dannazione (le parti di basso incise per forza di cose da sei mani diverse) quando non di pura, letterale morte (la comparsa sul finale di un L.G. Petrov riemerso dall’aldilà e pertanto irriconoscibile) è la stessa che esala da tre decadi a questa parte dai terreni pestati con passo inarrestabile dagli svedesi, sui quali lo stivale dei Marduk si conferma quello capace di regalare i calci in bocca più dolorosi di sempre.”


 Di veterani in veterani, un disco di commilitoni degli svedesi che sembra impossibile non sia il disco numero uno del mese per tutti: “How It Ends” degli irlandesi Primordial, album numero dieci per un’altra formazione storica che non smette di sfidarsi e sfidare tutti i suoi ascoltatori con musica di sicura difficile digestione, pensata e fatta per rimanere in controtendenza con ogni velocità moderna – come l’impegnato “Exile Amongst The Ruins” che va a seguire.
Di veterani in veterani, un disco di commilitoni degli svedesi che sembra impossibile non sia il disco numero uno del mese per tutti: “How It Ends” degli irlandesi Primordial, album numero dieci per un’altra formazione storica che non smette di sfidarsi e sfidare tutti i suoi ascoltatori con musica di sicura difficile digestione, pensata e fatta per rimanere in controtendenza con ogni velocità moderna – come l’impegnato “Exile Amongst The Ruins” che va a seguire.
![]() “L’emozione che si può provare all’ascolto di un qualunque disco dei Primordial fa rima più che mai con predisposizione. Non allo stile, non al genere proposto; bensì al messaggio, alle sensazioni di cui il fu quintetto -e oggi quartetto- sembra non voler davvero rendere partecipe qualcuno in particolare venendogli incontro. Per questo il discorso portato avanti dai Primordial è quello di un’emozione pura sì da scoprire con svariati ascolti, ma radicata in una innata predisposizione d’animo: o la senti nel profondo, o non la sentirai mai. Difficile trovare una via di mezzo – o colpisce in pieno rendendosi un tarlo, beninteso al netto di un impegno comunque sempre sprezzantemente richiesto, oppure non colpirà presumibilmente affatto. “How It Ends” non solo non fa eccezione, ma si dimostra probabilmente ad oggi uno dei dischi di più difficile assunzione della band; uno in cui gli intenti sono sempre chiari e mai nuovi, ma il cui raggiungimento richiede pazienza, persino amore, e una certa testardaggine pari a quella dei suoi creatori. La ricompensa è un nuovo disco importante, longevissimo: su cui riflettere, con cui vivere nuove considerazioni e maturare pensieri che, al solito, accompagneranno se lo vorremo per il resto dell’esistenza.”
“L’emozione che si può provare all’ascolto di un qualunque disco dei Primordial fa rima più che mai con predisposizione. Non allo stile, non al genere proposto; bensì al messaggio, alle sensazioni di cui il fu quintetto -e oggi quartetto- sembra non voler davvero rendere partecipe qualcuno in particolare venendogli incontro. Per questo il discorso portato avanti dai Primordial è quello di un’emozione pura sì da scoprire con svariati ascolti, ma radicata in una innata predisposizione d’animo: o la senti nel profondo, o non la sentirai mai. Difficile trovare una via di mezzo – o colpisce in pieno rendendosi un tarlo, beninteso al netto di un impegno comunque sempre sprezzantemente richiesto, oppure non colpirà presumibilmente affatto. “How It Ends” non solo non fa eccezione, ma si dimostra probabilmente ad oggi uno dei dischi di più difficile assunzione della band; uno in cui gli intenti sono sempre chiari e mai nuovi, ma il cui raggiungimento richiede pazienza, persino amore, e una certa testardaggine pari a quella dei suoi creatori. La ricompensa è un nuovo disco importante, longevissimo: su cui riflettere, con cui vivere nuove considerazioni e maturare pensieri che, al solito, accompagneranno se lo vorremo per il resto dell’esistenza.”
![]() “L’attesa durata ben cinque anni da “Exile Amongst The Ruins” rende “How It Ends” un disco densissimo, solido nei suoi dieci lunghi brani e complesso, forse impossibile da abbracciare nella sua interezza in pochi ascolti; non per bruschi scossoni stilistici, in quanto non rappresenta in ogni caso un punto di rottura nella discografia degli irlandesi, ma per la sottigliezza e la varietà sotterranea con cui gli elementi che caratterizzano il progetto caratterizzano a loro volta, ognuno, i singoli brani. Le scelte ritmiche sfociano in un folklore nuovamente in evidenza, sottolineato da un batterismo sospeso fra percussionismo e marzialità, ma aleggia grave un sentore drammatico dai toni marcatamente apocalittici, che dal Metal estremo prendono più gli aspetti sulfurei e gli spazi opprimenti che i tempi serrati. Quella tanto tipica sensazione di ribellione romantica e di amara disillusione che i Primordial riescono a trasmettere ormai da anni si tinge insomma in “How It Ends” di un fatalismo ancora più nero.”
“L’attesa durata ben cinque anni da “Exile Amongst The Ruins” rende “How It Ends” un disco densissimo, solido nei suoi dieci lunghi brani e complesso, forse impossibile da abbracciare nella sua interezza in pochi ascolti; non per bruschi scossoni stilistici, in quanto non rappresenta in ogni caso un punto di rottura nella discografia degli irlandesi, ma per la sottigliezza e la varietà sotterranea con cui gli elementi che caratterizzano il progetto caratterizzano a loro volta, ognuno, i singoli brani. Le scelte ritmiche sfociano in un folklore nuovamente in evidenza, sottolineato da un batterismo sospeso fra percussionismo e marzialità, ma aleggia grave un sentore drammatico dai toni marcatamente apocalittici, che dal Metal estremo prendono più gli aspetti sulfurei e gli spazi opprimenti che i tempi serrati. Quella tanto tipica sensazione di ribellione romantica e di amara disillusione che i Primordial riescono a trasmettere ormai da anni si tinge insomma in “How It Ends” di un fatalismo ancora più nero.”
![]() “Non avrebbe avuto il benché minimo senso anche solo tentare di superare le colonne d’Ercole erette da “Exile Amongst The Ruins”, opera dalla cupezza raggiunta poche altre volte persino nel curriculum vitae dei dublinesi, e forse è stato proprio tale pensiero ad indirizzare il da poco quartetto verso qualcosa di diverso, di rigoroso e per certi versi più asciutto pur nel dramma trasposto con la solita carica senza eguali. La stoica figura dell’uomo armato soltanto di una misera rivoltella e di un ideale infrangibile riassume alla perfezione i Primordial di oggi, il cui proposito, un lustro dopo quel fatale sguardo nell’abisso del mondo moderno, è di riempire tale vuoto pneumatico dando fondo al proprio carico di tensioni Folk ed Heavy Metal. Ne esce fuori con l’enigmatico titolo di “How It Ends” una sorta di rilettura dei due capitoli rilasciati sotto Hammerheart, dove la crudezza, la fiera povertà di mezzi di quel periodo si scontra con gli oltre vent’anni di esperienza da allora trascorsi, per uscirne poi rafforzata da tutta la maturità compositiva accumulata dai non più giovanissimi irlandesi.”
“Non avrebbe avuto il benché minimo senso anche solo tentare di superare le colonne d’Ercole erette da “Exile Amongst The Ruins”, opera dalla cupezza raggiunta poche altre volte persino nel curriculum vitae dei dublinesi, e forse è stato proprio tale pensiero ad indirizzare il da poco quartetto verso qualcosa di diverso, di rigoroso e per certi versi più asciutto pur nel dramma trasposto con la solita carica senza eguali. La stoica figura dell’uomo armato soltanto di una misera rivoltella e di un ideale infrangibile riassume alla perfezione i Primordial di oggi, il cui proposito, un lustro dopo quel fatale sguardo nell’abisso del mondo moderno, è di riempire tale vuoto pneumatico dando fondo al proprio carico di tensioni Folk ed Heavy Metal. Ne esce fuori con l’enigmatico titolo di “How It Ends” una sorta di rilettura dei due capitoli rilasciati sotto Hammerheart, dove la crudezza, la fiera povertà di mezzi di quel periodo si scontra con gli oltre vent’anni di esperienza da allora trascorsi, per uscirne poi rafforzata da tutta la maturità compositiva accumulata dai non più giovanissimi irlandesi.”
 I nuovi nemici pubblici numero uno del sempre più abbandonato social blu, ovvero i M8l8th di “Nekrokrator” che, per farla brevissima, ci regalano il loro disco più grande di sempre. Tanto si è infatti detto negli anni sul web nei loro riguardi: probabilmente troppo e male, dal momento che quasi sempre si è mancato il vero punto della questione banalizzando una proposta che, in fondo, banale non è davvero mai stata.
I nuovi nemici pubblici numero uno del sempre più abbandonato social blu, ovvero i M8l8th di “Nekrokrator” che, per farla brevissima, ci regalano il loro disco più grande di sempre. Tanto si è infatti detto negli anni sul web nei loro riguardi: probabilmente troppo e male, dal momento che quasi sempre si è mancato il vero punto della questione banalizzando una proposta che, in fondo, banale non è davvero mai stata.
![]() “Se “Reconquista” poteva suonare dopo cinque anni uno scarto di lato rispetto all’ambizioso “The Black March Saga” per via di una rifinitura compositiva nettamente migliorata ma anche di una disorganicità ed una povertà complessiva di fondo che gli conferiva una natura a tratti più compilativa che non cinematica, privata insomma della forza insita nel suo storytelling, “Nekrokrator” corregge ogni possibile tiro regalando invece cinque anni dopo a sua volta un disco che -persino tra coloro i quali hanno negli anni donato la giusta attenzione agli interessanti sviluppi musicali del progetto- non ci si poteva assolutamente aspettare. Più Folk (“Звероглавые Стяги Солнца“); più tragico e sofisticatamente marziale (“Святилище Моё Пребудет Памятью О Моей Славе“); più inventivo e funambolico (“В Пелене Тумана“) nella plateale ed impensabile varietà di soluzioni che propone tra velocità assassine (“Асов Рок”) e pathos sinfonico, orchestrale e complessivo eccezionale (“Моим Богам“); e dunque in generale forte, completo, coraggioso, maturato e soddisfacente quanto raramente il Black Metal dal cuore ad Est dell’Occidente.”
“Se “Reconquista” poteva suonare dopo cinque anni uno scarto di lato rispetto all’ambizioso “The Black March Saga” per via di una rifinitura compositiva nettamente migliorata ma anche di una disorganicità ed una povertà complessiva di fondo che gli conferiva una natura a tratti più compilativa che non cinematica, privata insomma della forza insita nel suo storytelling, “Nekrokrator” corregge ogni possibile tiro regalando invece cinque anni dopo a sua volta un disco che -persino tra coloro i quali hanno negli anni donato la giusta attenzione agli interessanti sviluppi musicali del progetto- non ci si poteva assolutamente aspettare. Più Folk (“Звероглавые Стяги Солнца“); più tragico e sofisticatamente marziale (“Святилище Моё Пребудет Памятью О Моей Славе“); più inventivo e funambolico (“В Пелене Тумана“) nella plateale ed impensabile varietà di soluzioni che propone tra velocità assassine (“Асов Рок”) e pathos sinfonico, orchestrale e complessivo eccezionale (“Моим Богам“); e dunque in generale forte, completo, coraggioso, maturato e soddisfacente quanto raramente il Black Metal dal cuore ad Est dell’Occidente.”
![]() “Inutile girarci intorno: “Nekrokrator” è di gran lunga il più bel disco che la formazione rifondata ucraina abbia mai composto in tutta la sua carriera. Se “Reconquista” completava un percorso sublimando quello stile muscolare fatto di cori e inni battaglieri, il nuovo album dei M8l8th fa invece leva su una verve epica e su una spiccata teatralità inedita, sperimentando complessi incastri vocali e soffiando a pieni polmoni negli ottoni che, gestiti in modo talvolta non dissimile da quelli di “Le Retour Des Pastoureaux” e soprattutto “Peste Noire Split Peste Noire” dei compari francesi, traboccano di melodie gloriose spesso e volentieri reggendo le redini dei brani. La band abbatte insomma con il suo nuovo lavoro dei limiti che sembravano invalicabili per gli intenti e la parabola della stessa formazione, azzardando e sperimentando scelte e idee che nell’ambiziosa ora di durata dimostrano un inaspettatissimo gusto sinfonico in grado di elevare all’ennesima potenza la loro grandiosità aurea e solenne.”
“Inutile girarci intorno: “Nekrokrator” è di gran lunga il più bel disco che la formazione rifondata ucraina abbia mai composto in tutta la sua carriera. Se “Reconquista” completava un percorso sublimando quello stile muscolare fatto di cori e inni battaglieri, il nuovo album dei M8l8th fa invece leva su una verve epica e su una spiccata teatralità inedita, sperimentando complessi incastri vocali e soffiando a pieni polmoni negli ottoni che, gestiti in modo talvolta non dissimile da quelli di “Le Retour Des Pastoureaux” e soprattutto “Peste Noire Split Peste Noire” dei compari francesi, traboccano di melodie gloriose spesso e volentieri reggendo le redini dei brani. La band abbatte insomma con il suo nuovo lavoro dei limiti che sembravano invalicabili per gli intenti e la parabola della stessa formazione, azzardando e sperimentando scelte e idee che nell’ambiziosa ora di durata dimostrano un inaspettatissimo gusto sinfonico in grado di elevare all’ennesima potenza la loro grandiosità aurea e solenne.”
![]() “La nuova fatica dei M8l8th arriva un po’ a sorpresa trattandosi di un disco inizialmente destinato per i soli acquirenti della copia fisica, scelta che nell’era di internet non mi pare particolarmente efficace – specialmente nel caso in cui il prodotto qui presente nasca con le intenzioni di trasmettere un certo tipo di messaggio in un periodo storico non particolarmente felice. Già dai primi minuti sia dal punto di vista musicale che lirico il tutto suona come un canto di guerra sospeso tra modernità e antichità, e sorprendentemente siamo di fronte alle migliori produzioni di sempre in casa M8l8th: il comparto sonoro è assolutamente in palla trovando la giusta combinazione tra qualità e quella tipica sensazione di crudezza ed organicità ormai marchio di fabbrica della band. L’aggiunta di vocalismi che spaziano poi tra uno scream straziante ed un pulito epico ed evocativo completano egregiamente la componente strumentale per dodici tracce al cardiopalma che riportano la formazione russo-ucraina all’assoluto apice del Black Metal Est europeo.”
“La nuova fatica dei M8l8th arriva un po’ a sorpresa trattandosi di un disco inizialmente destinato per i soli acquirenti della copia fisica, scelta che nell’era di internet non mi pare particolarmente efficace – specialmente nel caso in cui il prodotto qui presente nasca con le intenzioni di trasmettere un certo tipo di messaggio in un periodo storico non particolarmente felice. Già dai primi minuti sia dal punto di vista musicale che lirico il tutto suona come un canto di guerra sospeso tra modernità e antichità, e sorprendentemente siamo di fronte alle migliori produzioni di sempre in casa M8l8th: il comparto sonoro è assolutamente in palla trovando la giusta combinazione tra qualità e quella tipica sensazione di crudezza ed organicità ormai marchio di fabbrica della band. L’aggiunta di vocalismi che spaziano poi tra uno scream straziante ed un pulito epico ed evocativo completano egregiamente la componente strumentale per dodici tracce al cardiopalma che riportano la formazione russo-ucraina all’assoluto apice del Black Metal Est europeo.”
 Quello che dovrebbe essere l’ultimo suggerimento di oggi, nella pratica ci conduce giusto a metà strada della processione di spettri: il quarto fantasma del settembre passato sono gli Shining con il numero undici, omonimo full-length per la curiosa nuova partner Napalm. Reduce a corto giro dal trionfo Høstsol, Niklas cambia la pressoché totalità dei soci ma non le cattive intenzioni o la bontà delle composizioni, creando il disco all-star molto più bello che blasonato.
Quello che dovrebbe essere l’ultimo suggerimento di oggi, nella pratica ci conduce giusto a metà strada della processione di spettri: il quarto fantasma del settembre passato sono gli Shining con il numero undici, omonimo full-length per la curiosa nuova partner Napalm. Reduce a corto giro dal trionfo Høstsol, Niklas cambia la pressoché totalità dei soci ma non le cattive intenzioni o la bontà delle composizioni, creando il disco all-star molto più bello che blasonato.
![]() “Il disco più adulto di sempre degli Shining è qui: l’omonimo album che fa tutto tranne che essere un album omonimo, rifuggendo i paralleli più comodi con gli ultra rappresentativi “V: Halmstad” e “X: Varg Utan Flock” (smentendo nel mentre le al solito calcolatamente bugiarde parole dell’istrionico frontman che lo vorrebbe presentare quale figlio gemello di una differenta line-up), è un ingannatore. Un disco che deve entrare sottopelle per realizzarsi nella mente dell’ascoltatore, con le sue lente discese -per certi versi richiamo dei primissimi capitoli discografici del monicker svedese- e con quelle sue significative, profonde riflessioni acustiche e quasi-Blues che ritrovano il genio melodico di Peter Huss ad affrontare l’interrotto quanto coraggioso discorso “IX: Everyone, Everything, Everywhere, Ends” con ancora più successo: allungando il timing, riempiendo di una ipnoticità malata progenie di “Total Utfrysning”, rimanendo impregnato dell’ormai più che inconfondibile Shining-sound-since-“The Eerie Cold” eppure suonando ancor più sincero, meno teatrico e senza filtro. Il ragazzo è diventato definitivamente uomo; e la sua creatura con lui.”
“Il disco più adulto di sempre degli Shining è qui: l’omonimo album che fa tutto tranne che essere un album omonimo, rifuggendo i paralleli più comodi con gli ultra rappresentativi “V: Halmstad” e “X: Varg Utan Flock” (smentendo nel mentre le al solito calcolatamente bugiarde parole dell’istrionico frontman che lo vorrebbe presentare quale figlio gemello di una differenta line-up), è un ingannatore. Un disco che deve entrare sottopelle per realizzarsi nella mente dell’ascoltatore, con le sue lente discese -per certi versi richiamo dei primissimi capitoli discografici del monicker svedese- e con quelle sue significative, profonde riflessioni acustiche e quasi-Blues che ritrovano il genio melodico di Peter Huss ad affrontare l’interrotto quanto coraggioso discorso “IX: Everyone, Everything, Everywhere, Ends” con ancora più successo: allungando il timing, riempiendo di una ipnoticità malata progenie di “Total Utfrysning”, rimanendo impregnato dell’ormai più che inconfondibile Shining-sound-since-“The Eerie Cold” eppure suonando ancor più sincero, meno teatrico e senza filtro. Il ragazzo è diventato definitivamente uomo; e la sua creatura con lui.”
![]() “I corridoi asfissianti che percorrono gli Shining collassano in un equilibrio fragile ma metodico, che li vede vulnerabili nel loro presentarsi meditativi ma rabbiosamente autodistruttivi: il groove tirapugni di “X: Varg Utan Flock” viene sfumato su tinte più dolorose, tanto che le sezioni più estreme del nuovo platter come la conclusiva e bellissima “Den Permanenta Sömnen Kallar” si costruiscono progressivamente, quasi con cinematografica calma e con un approccio molto più graduale ed intimistico. Se il pensiero comune vuole che a prendere il nome di un progetto sia un disco che ne incorpora tutti gli elementi più distintivi, “XI: Shining” potrebbe tradire le aspettative di molti ascoltatori per il suo desiderio di essere sì manifesto artistico, ma al contempo distantissimo dalla definizione di compendio: gli svedesi (a metà) scavano a fondo nel cuore e nella psiche del progetto inseguendo le spire insidiose e malsane di costruzioni lente e circolari, che si evolvono con un’eleganza che fa emergere tutta l’attenzione e la cura infusa in una release che, nonostante necessiti più tempo del normale per far presa e lasciare il segno, sicuramente farà breccia nelle anime storte dei più ostinati.”
“I corridoi asfissianti che percorrono gli Shining collassano in un equilibrio fragile ma metodico, che li vede vulnerabili nel loro presentarsi meditativi ma rabbiosamente autodistruttivi: il groove tirapugni di “X: Varg Utan Flock” viene sfumato su tinte più dolorose, tanto che le sezioni più estreme del nuovo platter come la conclusiva e bellissima “Den Permanenta Sömnen Kallar” si costruiscono progressivamente, quasi con cinematografica calma e con un approccio molto più graduale ed intimistico. Se il pensiero comune vuole che a prendere il nome di un progetto sia un disco che ne incorpora tutti gli elementi più distintivi, “XI: Shining” potrebbe tradire le aspettative di molti ascoltatori per il suo desiderio di essere sì manifesto artistico, ma al contempo distantissimo dalla definizione di compendio: gli svedesi (a metà) scavano a fondo nel cuore e nella psiche del progetto inseguendo le spire insidiose e malsane di costruzioni lente e circolari, che si evolvono con un’eleganza che fa emergere tutta l’attenzione e la cura infusa in una release che, nonostante necessiti più tempo del normale per far presa e lasciare il segno, sicuramente farà breccia nelle anime storte dei più ostinati.”
![]() “La soglia dei quarant’anni di esistenza terrena spaventa in fin dei conti un po’ chiunque, e non fa certo eccezione un Niklas Kvarforth il quale, per chi se lo fosse scordato, resta una persona comune pur con le sue molteplici bizzarrie. Per chi segue da tempo il progetto, le premesse per il suo undicesimo sforzo discografico non erano esattamente le migliori tra copertina biancheggiante e assenza ufficiale di numero introduttivo; e invece ecco che l’album omonimo dei nuovamente rimaneggiati Shining dribbla ogni parvenza d’autocelebrazione temuta da chi si ricordava come tale l’alterno “Redefining Darkness”, mantenendo ben salda la fortissima personalità del brand svedese senza per questo risparmiarsi corpose pause di riflessione acustica trainate da chitarra e pianoforte, e gestite con un’eleganza assoluta la quale non fa certo rimpiangere l’impatto più frontale di altri celebrati episodi. Nulla di formalmente troppo nuovo nemmeno per il monicker, a ben sentire, ma persino in assenza di pericoli imminenti le strade di Halmstad mettono ancora addosso gli stessi maledetti brividi di sempre.”
“La soglia dei quarant’anni di esistenza terrena spaventa in fin dei conti un po’ chiunque, e non fa certo eccezione un Niklas Kvarforth il quale, per chi se lo fosse scordato, resta una persona comune pur con le sue molteplici bizzarrie. Per chi segue da tempo il progetto, le premesse per il suo undicesimo sforzo discografico non erano esattamente le migliori tra copertina biancheggiante e assenza ufficiale di numero introduttivo; e invece ecco che l’album omonimo dei nuovamente rimaneggiati Shining dribbla ogni parvenza d’autocelebrazione temuta da chi si ricordava come tale l’alterno “Redefining Darkness”, mantenendo ben salda la fortissima personalità del brand svedese senza per questo risparmiarsi corpose pause di riflessione acustica trainate da chitarra e pianoforte, e gestite con un’eleganza assoluta la quale non fa certo rimpiangere l’impatto più frontale di altri celebrati episodi. Nulla di formalmente troppo nuovo nemmeno per il monicker, a ben sentire, ma persino in assenza di pericoli imminenti le strade di Halmstad mettono ancora addosso gli stessi maledetti brividi di sempre.”

 …cosa? Che ci fosse un quinto disco in una rassegna storicamente da quattro l’avevamo anticipato, ma che si potesse trattare di una band fino a ieri dedita ai suoni vintage di uno Psychedelic-Folk Rock dall’anima storta e pagana? Sì, gli Hexvessel hanno scritto un disco Black Metal che definire Black Metal sembra al contempo un azzardo quanto una assoluta ovvietà. Un paradosso, in altri termini: come lo sono sempre stati i più grandi album di questo genere di musica.
…cosa? Che ci fosse un quinto disco in una rassegna storicamente da quattro l’avevamo anticipato, ma che si potesse trattare di una band fino a ieri dedita ai suoni vintage di uno Psychedelic-Folk Rock dall’anima storta e pagana? Sì, gli Hexvessel hanno scritto un disco Black Metal che definire Black Metal sembra al contempo un azzardo quanto una assoluta ovvietà. Un paradosso, in altri termini: come lo sono sempre stati i più grandi album di questo genere di musica.
![]() “Una sorpresa a dir nulla, “Polar Veil” (Svart Records): una nuova identità che si carica di un bagaglio culturale e stilistico non del tutto nuovo per i finlandesi (si pensi ai frequenti incupimenti Doom e quelli armonici virati di nero nelle interessanti distonie di “When We Are Death” e soprattutto “No Holier Temple”), i quali dopo aver abbracciato per una vita intera il Black Metal come linguaggio dello spirito nella persona del mastermind Mathew McNerney (il CV, in fatto di oscurità assortita al di fuori degli Hexvessel parla del resto chiaro: “Posthuman”, “Nouveau Gloaming”, “Resplendent Grotesque”, “Supervillain Outcast”, “Climax” e “Demon Solar Totem” sono solo alcuni titoli in oltre quindici anni di arco temporale che con costanza coprono) si addentrano nella foresta più buia e notturna compongonendo come fosse una assoluta necessità e con la naturalezza dei trasformisti più puri un disco di una solennità maestosa – difficile da descrivere per il mélange di musica e voce che propone, e che lo rende praticamente perfetto nonché assolutamente unico al mondo.”
“Una sorpresa a dir nulla, “Polar Veil” (Svart Records): una nuova identità che si carica di un bagaglio culturale e stilistico non del tutto nuovo per i finlandesi (si pensi ai frequenti incupimenti Doom e quelli armonici virati di nero nelle interessanti distonie di “When We Are Death” e soprattutto “No Holier Temple”), i quali dopo aver abbracciato per una vita intera il Black Metal come linguaggio dello spirito nella persona del mastermind Mathew McNerney (il CV, in fatto di oscurità assortita al di fuori degli Hexvessel parla del resto chiaro: “Posthuman”, “Nouveau Gloaming”, “Resplendent Grotesque”, “Supervillain Outcast”, “Climax” e “Demon Solar Totem” sono solo alcuni titoli in oltre quindici anni di arco temporale che con costanza coprono) si addentrano nella foresta più buia e notturna compongonendo come fosse una assoluta necessità e con la naturalezza dei trasformisti più puri un disco di una solennità maestosa – difficile da descrivere per il mélange di musica e voce che propone, e che lo rende praticamente perfetto nonché assolutamente unico al mondo.”
![]() “Il manto degli Hexvessel muta insieme allo scorrere stagioni, in un coerente spirito naturalistico e liberamente artistico come pochi: laddove le visioni confortevoli e più calde dei due precedenti full-length rischiavano di sfociare in una impasse stilistica, i paesaggi bianchi e tormentati di “Polar Veil” tracciano al contrario un freschissimo mosaico cristallino d’idee, sensazioni e generi fra i più particolari e sfaccettati degli ultimi anni. Delicato, struggente e sospeso a fluttuare sul quel tipico rumoroso silenzio ovattato e nevoso che solo la più talentuose formazioni riescono ad ottenere, i finlandesi fanno leva per la primissima volta su strutture di stampo tipicamente Black Metal, notturne e maledette, che ancora più che come strumento viene abbracciato a livello epidermico e concettuale, nelle fibre e nella sua essenza più pura e originaria. Un disco da ascoltare a tutti i costi sia che siate già adepti di lunga data della formazione capitanata da Kvohst (non a caso), sia che siate dei cosiddetti blackster dallo spirito psichedelico e avanguardistico.”
“Il manto degli Hexvessel muta insieme allo scorrere stagioni, in un coerente spirito naturalistico e liberamente artistico come pochi: laddove le visioni confortevoli e più calde dei due precedenti full-length rischiavano di sfociare in una impasse stilistica, i paesaggi bianchi e tormentati di “Polar Veil” tracciano al contrario un freschissimo mosaico cristallino d’idee, sensazioni e generi fra i più particolari e sfaccettati degli ultimi anni. Delicato, struggente e sospeso a fluttuare sul quel tipico rumoroso silenzio ovattato e nevoso che solo la più talentuose formazioni riescono ad ottenere, i finlandesi fanno leva per la primissima volta su strutture di stampo tipicamente Black Metal, notturne e maledette, che ancora più che come strumento viene abbracciato a livello epidermico e concettuale, nelle fibre e nella sua essenza più pura e originaria. Un disco da ascoltare a tutti i costi sia che siate già adepti di lunga data della formazione capitanata da Kvohst (non a caso), sia che siate dei cosiddetti blackster dallo spirito psichedelico e avanguardistico.”
Come promesso e preannunciato, in chiusura di questo recap di mese arricchito al plutonio abbiamo svariati altri consigli da dispensare. Si parte dagli spifferati ultimi due full-length: due lavori che, nonostante il riflettore ne abbia già colpiti altri cinque, non potevano assolutamente non guadagnarsi uno spazio che fosse maggiore della solita mezza riga in conclusione, unicamente riservati come sarebbero altrimenti stati solamente al più vorace o predisposto ascoltatore.
 Che siate dunque affezionati fan o meno poco importa di fronte alla riuscita di un disco come “Et Hav Av Avstand” – ennesimo album di grande profondità e ambizione della rassegna di oggi che non fallisce nel mostrarci i Taake, in barba a qualunque superficiale e pressapochista giudizio ignorante letto in giro per sbaglio (scritto dallo scemo di turno commettendo uno sbaglio ancor peggiore), come ancora in nessuna occasione la band di Hoest si era mostrata fino ad oggi. Composizioni lunghe quanto mai prima d’ora (si superano gli undici minuti in tre su quattro e si sfiora il quarto d’ora nella conclusiva) con un flair progressivo che ha fatto gustare l’ottavo disco in studio dell’istituzione di Bergen alla totalità dello staff tanto quanto non accadeva da molti anni a questa parte, facendo trovare la quadra alle lungaggini innocue dell’evitabilissimo e francamente noioso “Kong Vinter” grazie alla ricercatezza ritmica di un “…Bjoergvin…” o di un “…Doedskvad” e alla personalità strenua di un suono da antologia che riprende “Stridens Hus” e ne fa un gioiello d’ipnogeno fascino autunnale tutto nuovo.
Che siate dunque affezionati fan o meno poco importa di fronte alla riuscita di un disco come “Et Hav Av Avstand” – ennesimo album di grande profondità e ambizione della rassegna di oggi che non fallisce nel mostrarci i Taake, in barba a qualunque superficiale e pressapochista giudizio ignorante letto in giro per sbaglio (scritto dallo scemo di turno commettendo uno sbaglio ancor peggiore), come ancora in nessuna occasione la band di Hoest si era mostrata fino ad oggi. Composizioni lunghe quanto mai prima d’ora (si superano gli undici minuti in tre su quattro e si sfiora il quarto d’ora nella conclusiva) con un flair progressivo che ha fatto gustare l’ottavo disco in studio dell’istituzione di Bergen alla totalità dello staff tanto quanto non accadeva da molti anni a questa parte, facendo trovare la quadra alle lungaggini innocue dell’evitabilissimo e francamente noioso “Kong Vinter” grazie alla ricercatezza ritmica di un “…Bjoergvin…” o di un “…Doedskvad” e alla personalità strenua di un suono da antologia che riprende “Stridens Hus” e ne fa un gioiello d’ipnogeno fascino autunnale tutto nuovo.
 E se settembre per il nostro Caldix è d’altro canto stato il personale mese della tripla M sopra ogni cosa, il terzo motivo che ne spiega l’affettuoso nomignolo sono i Manii di “Innerst I Mørket”, uscito per Terratur Possessions e dalla mente dell’altro reduce dal successo di “Länge Leve Döden”, del quale è stata apprezzatissima “la scelta di appoggiarsi su una traccia singola; probabilmente la cosa migliore che i Manii potessero mai pensare di fare. Il senso di continuinità dato da questo tipo di struttura compositiva permette all’ambientazione di esprimere al meglio tutti i propri connotati tetri, struggenti e privi di luce. “Innerst I Mørket” è un disco che ti catapulta nel suo immaginario di disperazione dal quale è difficile uscirne regalando un senso di immedesimazione unico nel suo genere”.
E se settembre per il nostro Caldix è d’altro canto stato il personale mese della tripla M sopra ogni cosa, il terzo motivo che ne spiega l’affettuoso nomignolo sono i Manii di “Innerst I Mørket”, uscito per Terratur Possessions e dalla mente dell’altro reduce dal successo di “Länge Leve Döden”, del quale è stata apprezzatissima “la scelta di appoggiarsi su una traccia singola; probabilmente la cosa migliore che i Manii potessero mai pensare di fare. Il senso di continuinità dato da questo tipo di struttura compositiva permette all’ambientazione di esprimere al meglio tutti i propri connotati tetri, struggenti e privi di luce. “Innerst I Mørket” è un disco che ti catapulta nel suo immaginario di disperazione dal quale è difficile uscirne regalando un senso di immedesimazione unico nel suo genere”.
E poi ci sono gli EP: i mini-album che molte voltre troppo ‘mini’ non sono. È l’ovvio caso di “Crypt Of Ancestral Knowledge”, non corposissimo ma qualitativamente eccellente coda e chiusura del ciclo “Primordial Arcana” degli statunitensi Wolves In The Throne Room (Relapse Records per acchiapparsi una copia fisica) i quali ci presentano due nuovi brani imperdibili per chiunque abbia goduto dell’ultimo full-length targato 2021, corredati di una seconda metà di sperimentalità assortita in quasi dieci minuti aggiuntivi ad ottima dimostrazione, strutturale se vogliamo, delle basi da sempre più eclettiche di quel che potrebbe sembrare del trio.
Gli ucraini Hate Forest invece ci regalano con l’eloquente “Sowing With Salt” (Osmose Productions) un quarto d’ora di nuovo, ottimo materiale nel granitico revival intrapreso con “Hour Of The Centaur” ed “Innermost”, accorpandolo felicemente per i meno fruitori del formato vinilico e più estimatori del celebre dischetto laser argentato al “Celestial Wanderer” (2020) che lo aveva preceduto nella linea d’aria di produzioni meno estese a firma Saenko. Chi invece d’altri sull’esteso ci è andato e resta consigliato, nonostante non abbia sfortunatamente raggiunto i livelli dei colleghi proposti fino a questo momento, sono due eccellenze nostrane nelle produzioni di Mystical Fullmoon e Deadly Carnage: entrambi tra i più coraggiosi sperimentatori negli ultimi tre lustri di musica nera in Italia. I primi tornano dopo quasi dieci anni di assenza con l’inaspettato e sinfonicissimo “Hermits Amidst The Marvels Of Darkness” (Zazen Sounds), suonando alla grande benché meno coraggiosi che nei due capitoli precedenti; i romagnoli, invece, proseguono con il ricercato “Endless Blue” il loro ormai marcato allontanamento dagli stilemi più oscuri e Black Metal in favore di una certa -si passi il termine- alcestizzazione e notevole apertura armonica profetizzata prima in “Chasm” (2016) e dosata nell’ultimo “Through The Void, Above The Suns” (2018) – nella fattispecie all’interno della pecora bianca “Divide”.
Dopo avervi suggerito a vario titolo un totale non esattamente trascurabile di undici lavori vi spiegherete forse il tempo che ha impiegato organizzare e stilare un articolo simile; così come vi spiegherete senza problemi il taglio brusco sulle anticipazioni d’ottobre che questa volta aspetteranno il loro spazio a tempo debito, tra un mesetto di clessidra rovesciata a partire da questo momento…
– Matteo “Theo” Damiani –